ovvero: dove cercare spunti per affrontare vecchie sfide in (semi)nuove vesti
di Mackda Ghebremariam Tesfau’
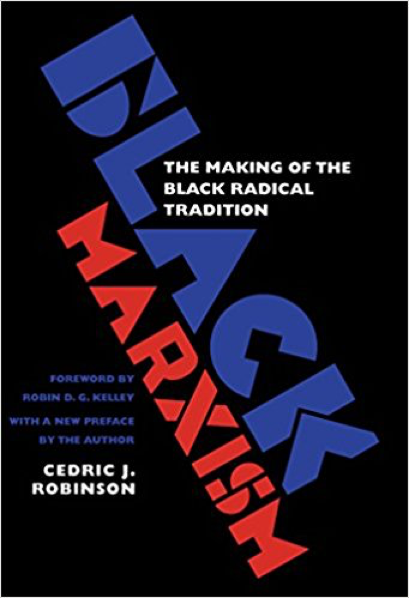 Il presente contributo vuole essere una circoscritta riflessione sull’opera di Cedric Robinson: Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (1983, 2000) a partire da alcune considerazioni legate alla peculiarità della situazione italiana e al revival delle destre nazionaliste in Europa. In particolare si tenterà di mettere in luce il significato che l’autore attribuisce a ciò che egli definisce “capitalismo razziale” (racial capitalism) e come tale concetto possa rivelarsi utile per ripensare la contemporaneità.
Il presente contributo vuole essere una circoscritta riflessione sull’opera di Cedric Robinson: Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (1983, 2000) a partire da alcune considerazioni legate alla peculiarità della situazione italiana e al revival delle destre nazionaliste in Europa. In particolare si tenterà di mettere in luce il significato che l’autore attribuisce a ciò che egli definisce “capitalismo razziale” (racial capitalism) e come tale concetto possa rivelarsi utile per ripensare la contemporaneità.
Per molti anni l’Italia ha rivendicato un’innocenza del tutto fittizia rispetto ai temi della razza e del colonialismo. Ciò è accaduto in parte grazie a un sofisticato lavoro di rimozione della vicenda coloniale italiana, inteso non semplicemente in senso psicologico sociale ma piuttosto in senso pratico e politico, in parte per ragioni storiche e contingenziali. Se da un lato infatti sia il colonialismo che il razzismo istituzionale sono stati considerati appannaggio dell’Italia fascista, e di conseguenza apparentemente sepolti assieme al ventennio che ne porta il nome, d’altro canto la depressione economica del dopoguerra ha fatto sì che l’Italia rimanesse un paese caratterizzato più da processi di emigrazione che di immigrazione. Il risultato di questo doppio ordine di eventi fu da un lato la totale omissione nel dibattito pubblico e nella storia ufficiale del paese dei crimini coloniali, dall’altro l’assenza di un soggetto collettivo che potesse svelare le contraddizioni latenti, ovvero il razzismo strutturale, di un’Italia che ha potuto in tal modo continuare ad immaginarsi come una “grande proletaria” bianca e piena di “brava gente”.
Tuttavia attorno agli anni ‘80 la penisola comincia ad essere interessata da flussi migratori che ne ridisegnano la composizione demografica, trasformandone il panorama sociale, economico e politico; così, con ampio ritardo rispetto ad altre potenze imperialiste europee quali Francia e Inghilterra, in Italia comincia timidamente ad affacciarsi lo spettro violento dell’alterità schiava e coloniale.
È il 1989 quando nella campagna casertana viene ucciso Jerry Essan Masslo, rifugiato sudafricano reo di non aver voluto consegnare ai suoi assalitori il misero guadagno ottenuto in due mesi di raccolta stagionale sotto caporalato. L’omicidio suscita un’ondata di indignazione nel dibattito pubblico, minando alla base l’ingenuo presupposto sull’assenza di un razzismo all’italiana (Hawthorne 2017, 164).
Nonostante l’avvenimento, tuttavia, non troviamo riscontri immediati nel panorama intellettuale e critico: se la ricerca sociale comincia infatti a interessarsi del fenomeno migratorio in Italia, è solo nel 1997 che compare il primo testo dedicato specificamente al razzismo. Si tratta di La pelle giusta, dell’antropologa femminista Paola Tabet, che conduce una ricerca in diverse scuole elementari e medie dimostrando come già nell’infanzia tra i giovani italiani sia presente un immaginario violentemente razzista.
È con i primi anni Duemila e con l’introduzione degli studi decoloniali e postcoloniali in Italia che ricercatori e accademici provenienti da diverse aree disciplinari cominciano ad interessarsi sia alla costruzione della bianchezza e della nerezza in Italia – riaprendo l’archivio coloniale e del dopoguerra per individuarne continuità e rotture (Petrovich Njegosh & Schacchi 2012, Giuliani & Lombardi Diop 2013, Giuliani 2015 etc.) – che al modo in cui tali differenze, attraverso i confini, vengono “messe a produzione” (Curcio & Mellino 2012, Mezzadra & Neilson 2013; etc.)
Ma a differenza del contesto britannico, francese e statunitense, in cui esiste ormai da tempo un corpus prodotto per, e a partire da, l’esperienza diasporica nera, in Italia la presa di parola dei soggetti “post” – coloniali è, salvo poche eccezioni, avvenuta all’interno del dominio artistico letterario. In altre parole non si è – ancora – sviluppato un set critico di saperi in lingua italiana che tratti la questione razziale da un posizionamento nero.
Ad oggi un’analisi del razzismo in Italia e in Europa è imprescindibile, essendo emersa con chiarezza la dimensione strutturale del fenomeno nella relazione che intrattiene con il nazionalismo e le trasformazioni delle politiche sui confini. I discorsi prodotti sulla questione dei migranti forzati e sulla cosiddetta “crisi dei rifugiati”, attorno ai quali si stanno mobilitando i partiti europei sia come forze politiche che come contenitori ideologici di narrazioni, ne sono la riprova. Tutto ciò trova conferma nei diversi risultati elettorali in Europa, in ultimo nelle recenti elezioni amministrative in Italia, nelle quali il tema dei richiedenti asilo, elemento centrale nelle diverse campagne, è divenuto lo strumento di una divisione dai tratti antropologici tra chi propone l’immagine apocalittica di un’invasione barbarica e chi sostiene invece una narrazione vittimistica e passivizzante dei migranti forzati, a cui l’Europa in virtù della sua indole umanitaria illuminista e universalistica dovrebbe offrire quell’accoglienza assistenzialista governata ed informata dal sistema post protocollo di Dublino. Queste posizioni apparentemente diverse si rivelano, ad un’analisi più attenta, come le due facce della stessa medaglia, ovvero due modi differenti in cui un’idea nazionalistica ed europea ritrova la sua centralità, escludendo nuovamente i soggetti “altri” di cui non riconosce le individualità, l’agency e il potenziale trasformativo.
Contemporaneamente dal 2015, è divenuto pressante in Italia il dibattito sulla riforma della cittadinanza – Ius soli temperato e Ius culturae –, dibattito che ha avuto l’effetto di svelare ulteriormente il sostrato razzista alla base delle posizioni avverse alla riforma.
 Il dibattito sullo Ius soli, così come le immagini dei migranti forzati – e facciamo attenzione, non immagini quali la tristemente famosa foto di Aylan o lo scatto di Messinis che ritrae una madre siriana nel campo di Lesbo[1], ma le immagini ritraenti i corpi neri e minacciosi dei giovani maschi africani che approdano a Lampedusa – risvegliano le mal sopite ansie razziste del Bel Paese che si concretizzano in ripetute aggressioni materiali e simboliche. Se infatti troppo spesso il dibattito pubblico occulta la dimensione razziale attraverso il lessico della migrazione – migranti, immigrati, rifugiati, profughi, seconde generazioni – altrettanto spesso la violenza nei confronti dei corpi neri riemerge con forza nelle pagine dei giornali, sui muri delle città, dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e nel linguaggio del razzismo istituzionale e non.
Il dibattito sullo Ius soli, così come le immagini dei migranti forzati – e facciamo attenzione, non immagini quali la tristemente famosa foto di Aylan o lo scatto di Messinis che ritrae una madre siriana nel campo di Lesbo[1], ma le immagini ritraenti i corpi neri e minacciosi dei giovani maschi africani che approdano a Lampedusa – risvegliano le mal sopite ansie razziste del Bel Paese che si concretizzano in ripetute aggressioni materiali e simboliche. Se infatti troppo spesso il dibattito pubblico occulta la dimensione razziale attraverso il lessico della migrazione – migranti, immigrati, rifugiati, profughi, seconde generazioni – altrettanto spesso la violenza nei confronti dei corpi neri riemerge con forza nelle pagine dei giornali, sui muri delle città, dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e nel linguaggio del razzismo istituzionale e non.
 E mentre le destre europee hanno successo nel capitalizzare il rigurgito nazionalista, riemergendo rinvigorite dal clima prodottosi dalla congiuntura tra crisi economico/politica e nuovi flussi migratori, le sinistre sembrano totalmente incapaci di ripensarsi attorno a un nuovo internazionalismo anti-razzista e di raccogliere la sfida che questa contemporaneità pone. È a partire da queste considerazioni che vorrei rivolgermi ora al testo di Cedric Robinson.
E mentre le destre europee hanno successo nel capitalizzare il rigurgito nazionalista, riemergendo rinvigorite dal clima prodottosi dalla congiuntura tra crisi economico/politica e nuovi flussi migratori, le sinistre sembrano totalmente incapaci di ripensarsi attorno a un nuovo internazionalismo anti-razzista e di raccogliere la sfida che questa contemporaneità pone. È a partire da queste considerazioni che vorrei rivolgermi ora al testo di Cedric Robinson.
Black Marxism esce per la prima volta nel 1983 per Zed Books, una casa editrice londinese. Il testo non incontra un grande successo di critica: fatto salvo per un’intempestiva recensione di Cornel West (1988) l’opera rimane sostanzialmente trascurata fino alla sua riedizione nel 2000 per The University of North Carolina Press. Le ragioni del successo tardivo dell’opera sono sicuramente diverse, ma ritengo che esso sia principalmente imputabile alla complessità e vastità del testo, fondamentalmente inattuale a causa dello scopo che si prefigge, ovvero la riscrittura di una macronarrazione che assuma la dimensione della razza a determinante storica, esattamente come nella trattazione marxiana avviene con il concetto di classe.
Contrariamente a quanto suggerisce il titolo, Black Marxism non è la storia di un marxismo nero, ovvero non è un momento di unione tra un marxismo “ortodosso” e un nazionalismo nero, bensì il tentativo di ripensare nuove strade di lotta a partire dalle mancanze e dai limiti della prospettiva marxista. Per Robinson infatti il marxismo rimane necessariamente impigliato nelle maglie della concettualità eurocentrica in quanto risultato di una teorizzazione europea sia nei suoi assunti che nella direzione che intraprende. Per tale ragione il marxismo risulterebbe incapace di operare un superamento di quelle categorie che informano la vicenda capitalista, annichilendo il ruolo fondamentale che il razzismo gioca nel processo di emersione del capitale.
Robinson, pur riconoscendo nel marxismo la forma dominante che il radicalismo anti-capitalista assume nel pensiero occidentale (Robinson 2000, 10), denuncia la segregazione delle istanze femministe, non-europee e contadine in un ordine pre-capitalista/non-capitalista e, citando Gunder Frank, conviene che Marx, tentando di rintracciare l’essenza del capitalismo unicamente nell’“eccezionalismo europeo”, fallisce nel rendere conto del sistema capitalistico così come esso si produce e riproduce nella realtà della geografia globale.
Black Marxism si divide in tre parti: The Emergence and limitations of European Radicalism, The Roots of Black Radicalism – in cui Robinson esplora la tratta atlantica e le forme di resistenza che la hanno caratterizzata – e Black Radicalism and Marxist Theory – dove l’autore chiama in causa l’opera dei tre grandi intellettuali neri W.E.B. du Bois, C.L.R. James e Richard Wright, al fine di mettere in luce il modo in cui il loro pensiero, pur nascendo all’interno del marxismo, lo “supera” parzialmente in direzione della valorizzazione di un radicalismo di classe e nero, quindi più marcatamente subalterno. Purtroppo non è possibile in questo spazio occuparci dell’opera intera, ragione per la quale mi soffermerò sulla prima parte, in cui l’autore illustra il concetto di racial capitalism.
Nella prima sezione, The Emergence and limitations of European Radicalism, Robinson ricostruisce – bisogna ammettere a tratti grossolanamente ma non potrebbe essere diversamente data la portata dello scopo – il percorso storico europeo. Per l’autore esiste una contraddizione tra i due movimenti contemporaneamente presenti all’alba della venuta del sistema capitalistico: da un lato la fiducia razionalistica nel sistema economico, dall’altro quello che egli definisce il “political momenta of collectivist logic”, ovvero le logiche attraverso le quali le diverse comunità europee si immaginano nella loro singolare unità e omogeneità. Robinson sostiene che il capitalismo, a differenza di quanto teorizzato dal marxismo, non si manifesti come rottura totale con le strutture del passato, bensì conservi in sé alcune determinanti feudali fondamentali, in particolare la struttura razzializzata del lavoro, spesso non libero, che è il segno del colonialismo interno che contraddistingue l’Europa premoderna e moderna. L’autore prende in esame in particolare la condizione di alcune minoranze: gli Ebrei, gli Slavi, i Rom, gli Irlandesi, mostrando come tali gruppi abbiano subito processi di razzializzazione, inferiorizzazione e sfruttamento che hanno anticipato il movimento coloniale extra-europeo. Ciò è riassunto nel concetto, ripreso dal nazional socialismo tedesco ma ad esso antecedente, di Herrenvolk, ovvero l’idea che esista una razza europea superiore legittimata a governare le altre. Inizialmente propugnato dalle classi dominanti e dalle borghesie nazionali, questo nazionalismo razzializzato ebbe bisogno, nel XIX secolo, della complicità del proletariato per divenire operativo. Lo stesso Marx ne era perfettamente cosciente quando trattava della questione irlandese e di come la dimensione etnico/razziale promuovesse una scissione in seno alla classe operaia inglese, incapace di distinguere la sua azione da quella delle classi dominanti rispetto alla colonizzazione dell’Irlanda e alla proletarizzazione dei suoi abitanti. L’impossibilità della working class inglese di smarcarsi dalla narrazione nazionalista borghese porta Marx a concludere che la causa operaia non potrà «mai nulla, prima che sia riuscita a disfarsi del problema irlandese. La leva si deve applicare in Irlanda. Per questo motivo la questione irlandese è così importante per il movimento sociale in generale»[2]. Come osserva Robinson, tuttavia, Marx non porta questa posizione alle sue estreme conseguenze, e l’analisi della distinzione tra proletariato e sottoproletariato razzializzato non diviene cruciale nella lotta per l’emancipazione. È esattamente a questa altezza che Robinson situa la critica a Marx e al radicalismo europeo, incapace di portare avanti una lotta dai tratti universali in quanto incardinata in una struttura concettuale ed esperienziale razzista.
Allo stesso modo Robinson critica il nazionalismo nero, che a suo avviso rischia di riprodurre, rovesciandola, la stessa struttura della dominazione eurocentrica, e valorizza invece tradizioni quali quella del marronaggio[3], in cui la comunità nera, più impegnata a salvaguardarsi che a sovvertire il sistema, nel ricostruirsi paradossalmente produce una risposta radicale, ovvero un’alternativa reale al capitalismo razziale.
Racial capitalism è un termine che Robinson prende dalla critica all’apartheid sudafricano e al sistema economico a cui dà luogo, generalizzandolo fino a rendere il termine descrittivo dell’intero sistema mondiale; il termine diviene quindi cruciale nell’identificare l’interdipendenza tra sistema capitalistico e razzismo strutturale. Se la razza, come è chiaro (Barbujani 2006), non esiste, altrettanto non si può dire dei suoi effetti. È infatti il processo di razzializzazione (Fanon 1952) a produrre la razza in tutta la sua verità effettuale di costruzione sociale. L’esperienza nera, d’altro canto, è un’esperienza diasporica, un “essere fuori posto” fondamentale, ed è esattamente questa dimensione a rendere possibile una generalizzazione nella differenza, ovvero a rendere possibile un discorso sulla global blackness e sul ruolo che tale blackness gioca all’interno del racial capitalism. Dobbiamo perciò pensare ad una sostanziale continuità tra la morte per mano fascista di Emmanuel Chidi Namdi a Fermo e il destino dei corpi neri al lavoro nei campi di pomodoro del sud Italia, tra lo stupro di Theo ad opera di un poliziotto francese, il numero di morti nere nel Mediterraneo e la violenza poliziesca razzista che ha risvegliato il movimento Black Lives Matter; ma soprattutto dobbiamo pensare tale continuità in senso diacronico in relazione alla schiavitù, al Black Atlantic (Gilroy 1993, Williams 1944) e al Black Mediterranean (Di Maio 2012, Robinson 2000).
Operando questo spostamento di prospettiva testi come Black Marxism – ma è uno di una lunghissima lista potenziale – possono essere utili a incorniciare le recenti ondate di xenofobia e razzismo – legate all’emergere delle nuove generazioni che fanno implodere le narrazioni nazionaliste di omogeneità culturale e razziale, e al fenomeno delle migrazioni forzate e non – in un quadro storico e politico più ampio. In tal modo storie che vengono immaginate come a sé stanti vengono “riconnesse” – connected histories (Bhambra 2007) – e con esse, in relazioni talvolta contraddittorie e conflittuali ma non per questo meno feconde, vengono riconnesse anche le diverse pratiche di resistenza sviluppatesi in antitesi alle strutture di dominio di razza, classe, di genere.
Riferimenti bibliografici
Barbujani G. (2006), L’invenzione delle razze: Capire la biodiversità umana, Milano, Bompiani.
Bhambra G.K. (2010), Historical sociology, international relations and connected histories, in “Cambridge Review of International Affairs”, vol.23, n.1.
West C. (1988), Black Marxism and the Marxist Tradition, in “Monthly Review”, September.
Curcio A. & Mellino M. (a cura di) (2012), La razza al lavoro, Roma, Manifestolibri.
Di Maio A. (2012), Mediterraneo Nero. Le rotte dei migranti nel millennio globale, in De Spuches G. (a cura di), La citta cosmopolita. Altre Narrazini vol.2, Palermo, Palumbo Editore.
Giuliani G. (a cura di) (2015), Il colore della nazione, Milano, Le Monnier Università.
Giuliani G. & Lombardi Diop C. (2013), Bianco e Nero: Storia dell’identità razziale degli italiani, Milano, Le Monnier Università.
Hawthorne C. (2017), In search of Black Italia, in Jalada 05/123 in collaborazione con Transition, Indiana University Press
Marx K. & Engels F. (1973), Sull’Irlanda, Roma, Napoleone Editore.
Mezzadra S. & Neilson B. (2013), Confini e frontiere: La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, Bologna, Il Mulino.
Petrovich Njegosh T. & Scacchi A. (a cura di) (2012), Parlare di razza, Verona, ombre corte.
Robinson C. (2000), Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition, Chapel Hill: NC, The University of North Carolina Press.
Williams E. (1944), Capitalism and slavery, Chapel Hill: NC, The University of North Carolina Press.
[1] https://correspondent.afp.com/war-peace
[2] In: Marx, K., Engels, F., Sull’Irlanda, p. 347; dove leggiamo anche: «Il suo atteggiamento [dell’operaio inglese] è molto simile a quello dei bianchi poveri nei confronti dei negri nei vecchi stati schiavistici degli Stati Uniti. L’irlandese gli restituisce tutto ciò con gli interessi» ivi 358.
[3] Con marronaggio si intende una pratica diffusa tra gli schiavi che consisteva nel fuggire dalla piantagione o dal luogo in cui si viveva in schiavitù per unirsi a comunità di fuggitivi, indigeni o fondare nuove comunità.
